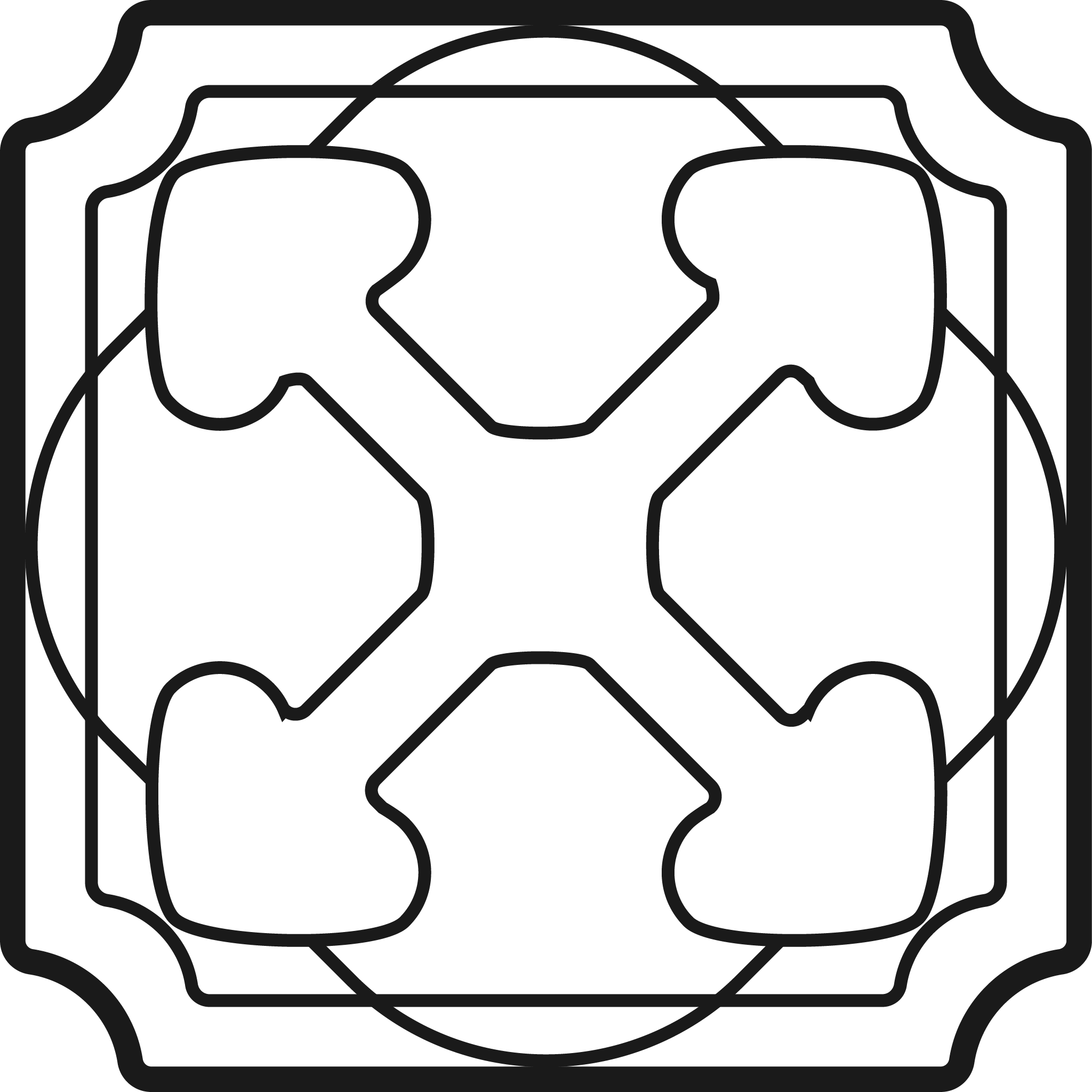
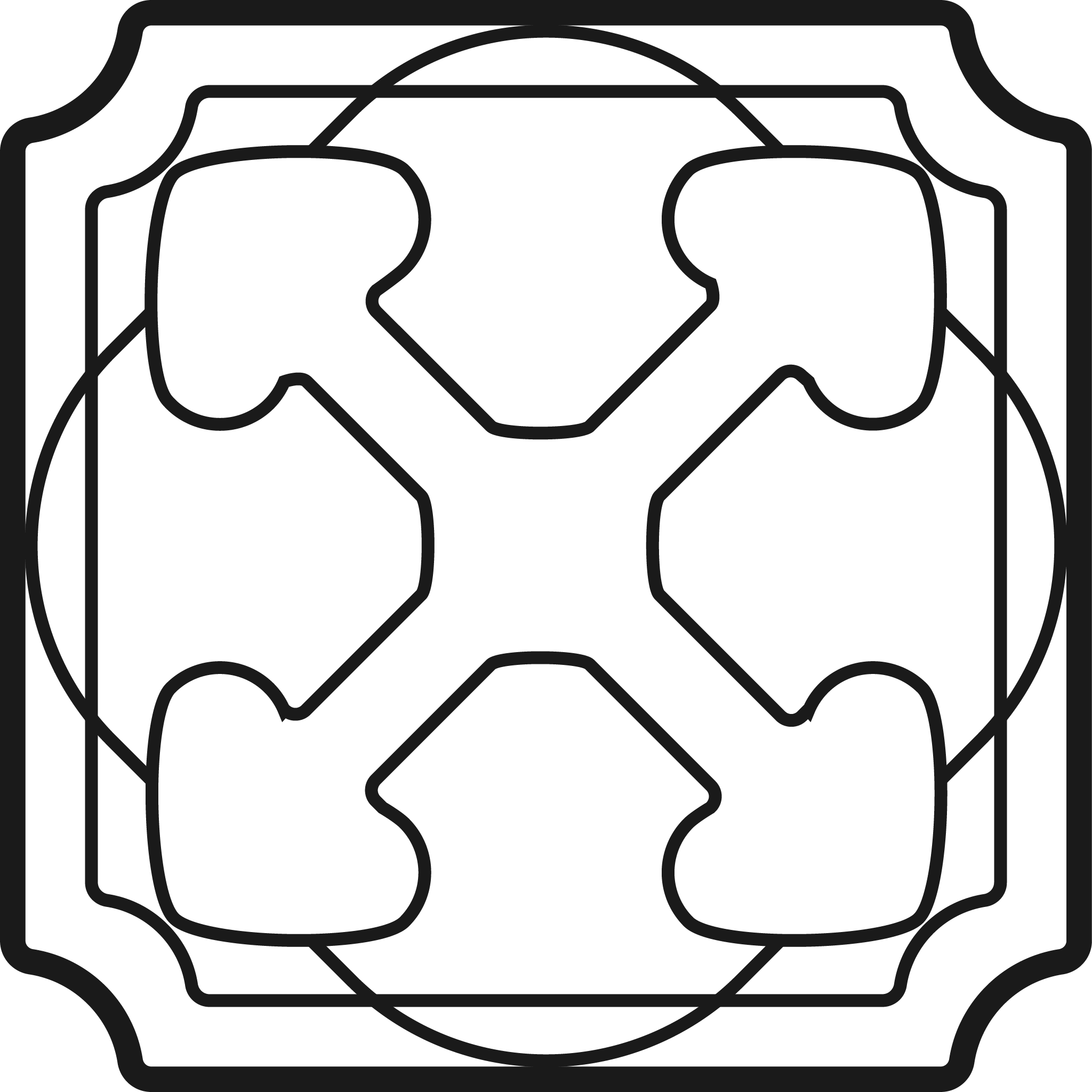
Nella storia dell’arte, le rappresentazioni del sole – a volte celeberrime, se pensiamo al dipinto di Monet Impression, soleil lavant – sono numerose e declinate in più interpretazioni: le due principali guardano al sole o come simbolo religioso e mitologico o come astro in una visione naturalistica.
Se nell’arte egizia era presente il mito della barca solare, molto più frequente risulta l’iconografia del carro di fuoco, in cui il sole viene trasportato nel cielo da Est a Ovest durante il giorno e in senso inverso di notte, come avviene nella mitologia greca coi carri di Apollo ed Elios.
Ritroviamo quest’immagine anche nella nostra Pinacoteca in relazione a San Francesco in un dipinto di Guido di Graziano, probabilmente realizzato tra gli anni ‘80 e ‘90 del Trecento. Si tratta di una tabula agiografica dedicata a san Francesco, cioè di un’opera che descrive la vita del santo, raffigurato al centro a figura intera, attraverso gli episodi più significativi tratti, in questo caso, dalla Legenda Maior di Bonaventura da Bagnoregio. La scena, presente anche negli affreschi di Giotto ad Assisi, si svolge durante il sonno dei confratelli: alcuni, svegli, vedono il santo, che si era appartato a pregare, salire al cielo su un carro infuocato ad illuminare tutt’intorno.
Entro questa dimensione assolutamente simbolica, potremmo quasi dire che i nostri autori più celebri – Duccio di Buoninsegna e Simone Martini in primis – utilizzassero i fondi oro per alludere alla luce spirituale in cui tutto è sole. Unica eccezione è Ambrogio Lorenzetti, noto anche grazie alla testimonianza di Ghiberti per aver saputo riprodurre in pittura fenomeni atmosferici, in particolare nel frammento, seppur lacunoso, con la Tempesta sulla città di Tana in India, già nel chiostro di San Francesco a Siena, esposto nella grande mostra senese del 2018.
Anche se i nostri artisti si attardano su un cielo ancora “dorato”, nel 1409 troviamo un primo notturno grazie al pennello di Taddeo di Bartolo, che nella predella del polittico dell’Annunciazione coi Santi Cosma e Damiano, ci illustra simultaneamente due momenti del racconto della Natività: da un lato i pastori addormentati in prossimità del gregge, risvegliati dall’angelo; dall’altro in adorazione di Gesù Bambino.
Uno dei primi cieli atmosferici nel nostro museo si deve a Stefano di Giovanni detto il Sassetta nello scomparto di predella della Pala dell’Arte della Lana (1423-1426), in cui dà prova del suo interesse per la ricerca spaziale e per le sperimentazioni dell’arte fiorentina coeva. Nel complesso programma iconografico del polittico, incentrato sul tema dell’Eucarestia, qui vediamo Sant’Antonio battuto dai diavoli: la scena si svolge all’aperto in un paesaggio di colline inospitali, in cui si possono forse intuire le prime luci dell’alba, come suggerisce il bellissimo cielo striato da sottili nuvole che domina lo sfondo.
Per vedere finalmente un sole splendente dobbiamo attendere i primi tentativi di realismo negli esordi pre-rinascimentali di Giovanni di Paolo, con un frammento di predella dedicato alla Fuga in Egitto, in cui possiamo ammirare il paesaggio senese traslato in una visione non troppo esotica: al di là del fiume, il viaggio dei personaggi sacri diventa un pretesto per descrivere il lavoro nei campi, che si svolge sotto un sole pieno, realizzato a rilievo, che illumina le colline all’orizzonte, ricoperte di foglia d’oro zecchino: l’oro è rimasto ma con funzioni decorative, ha finalmente lasciato il posto a un cielo azzurro, punteggiato di rondini in volo, e la luce – forse la radenza suggerisce quella del primo mattino – ha persino provocato ombre portate.
Sano di Pietro per primo introduce il sole più ricorrente della Pinacoteca: il Santo nome di Gesù, IHS, spesso riferito a San Bernardino da Siena. Predicatore già notissimo al tempo, san Bernardino (1380-1444) non solo utilizzava questa tavoletta mostrandola sul leggio da cui parlava, ma invitava l’uditorio ad apporre sulle facciate delle case questo simbolo, forse il primo vero “logo” della storia, come emblema protettivo e di benvenuto (“Portalo addosso, o scritto o figurato, e non potrai capitar male”). Il sole bernardiniano rimanda dunque alla ricorrente personificazione della Verità divina, luce che rivela ogni cosa.
Sullo scorcio del Cinquecento, Andrea di Niccolò, nella Crocifissione coi santi Benedetto e Scolastica, ci regala, con tonalità fredde, il sole e la luna: se dai Vangeli sinottici si legge di un’eclissi da Mezzogiorno alle tre del pomeriggio, quasi un lutto dei cieli per la morte del Redentore, nelle parole di sant’Agostino si intravede una connessione fra i due testamenti, e l’Antico (la luna) si può comprendere solo grazie al Nuovo (il sole).
L’opera di Marcello Venusti, allievo di Michelangelo, nella sua Samaritana al Pozzo esibisce in un’inaspettata avventura cromatica, che risente della lezione coloristica veneta, attraversata da un’inquietudine poetica già manieristica, in uno dei rarissimi tramonti del nostro museo.
approfondimento a cura di Elisa Bruttini, funzionaria storica dell’arte dei Musei Nazionali di Siena