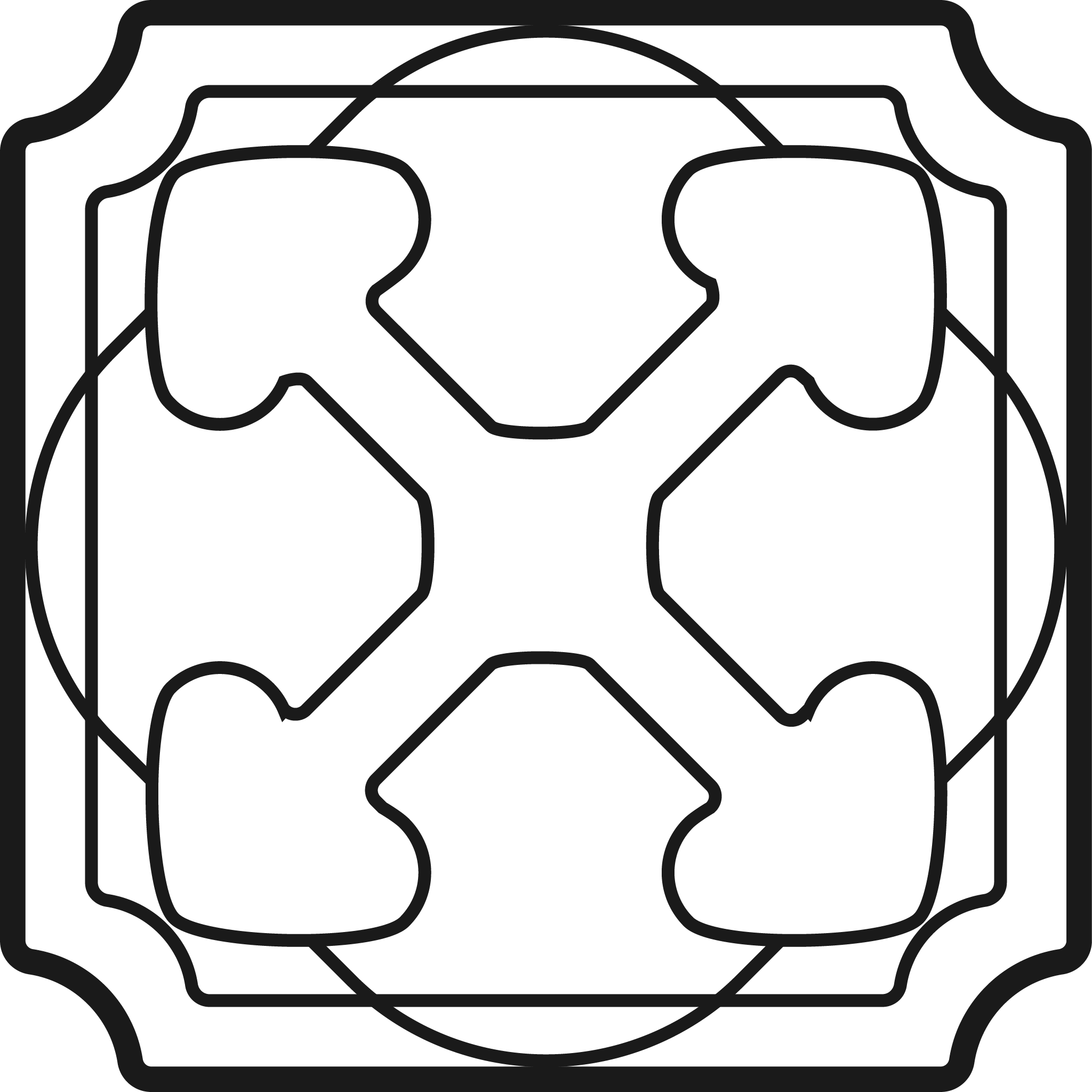
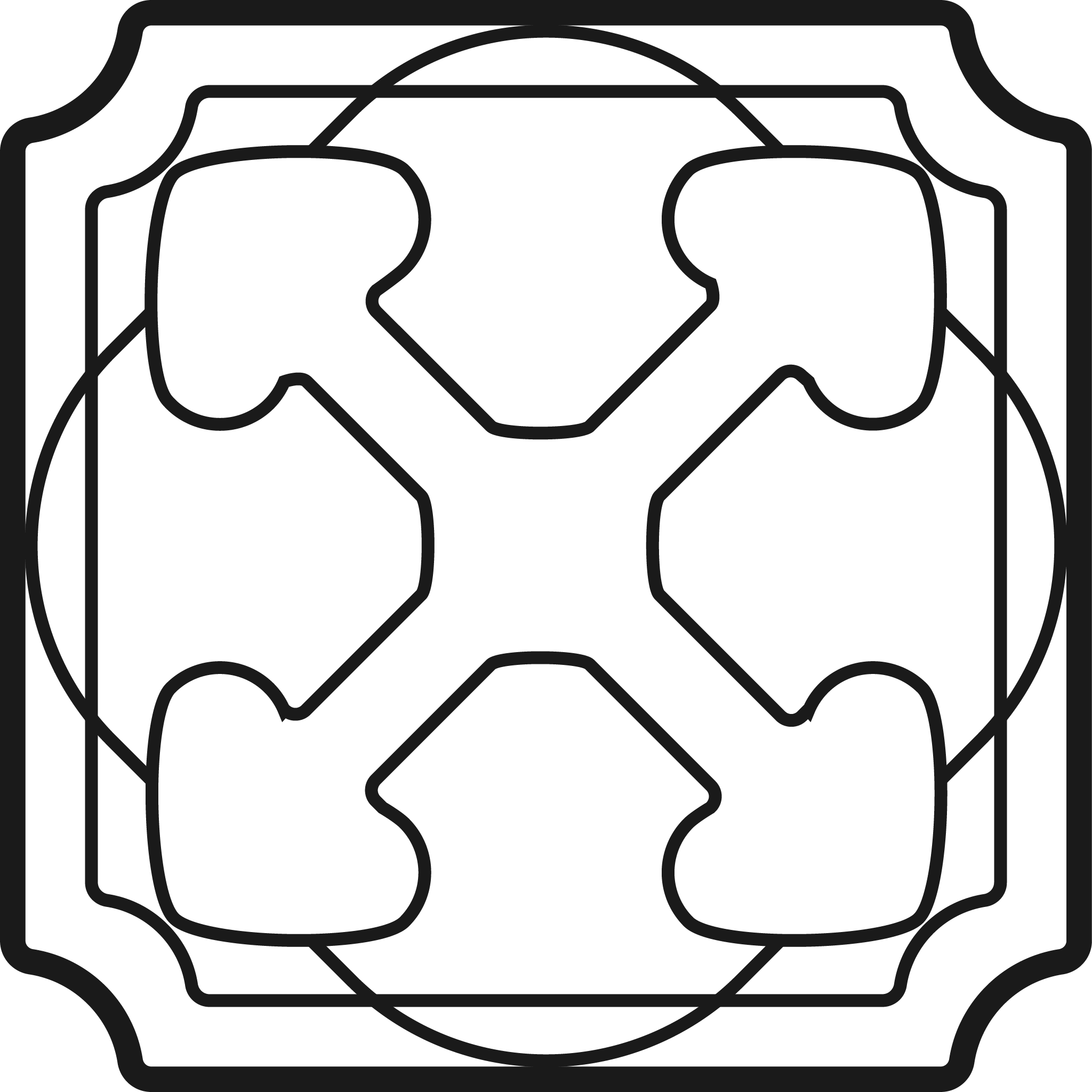
Una barchetta di legno a remi galleggia sul mare. Due pescatori, la rete già piena, si voltano verso un uomo in piedi sulla riva rocciosa. È la Vocazione di San Pietro, nel pannello laterale del Dossale di San Pietro di Guido di Graziano (seconda metà del Duecento). La scena colpisce per la vivacità dei gesti, per i colori accesi, ma anche perché i pittori medievali non rappresentano così spesso il mare. Questo, in realtà, non è un mare: è il Lago di Tiberiade, detto anche Mar di Galilea, un grande bacino d’acqua dolce, oggi al confine tra Israele e Siria. Qui è ambientato questo episodio fondante del Vangelo (insieme a tanti altri): i due pescatori sono Pietro ed Andrea e lasceranno le reti per seguire Cristo e diventare suoi discepoli. Nell’antichità, in effetti, il lago di Tiberiade era ricco di fauna e pescoso, ma Guido di Graziano, pittore contemporaneo a Duccio, difficilmente poteva averlo visto. Di lui non sappiamo molto: un nome nei documenti, poche opere certe, realizzò anche miniature e tavole di biccherna (le copertine dei registri contabili del Comune).
Ma Guido avrà visto almeno il mare a lui più vicino? Dal suo Terzo di Camollia, il quartiere di Siena dove abitava, si sarà spinto una volta fino alla costa del Tirreno, a quel tempo inospitale e malarica? Forse no. Nel Duecento il mare non era un luogo di vacanza. Nell’immaginario medievale, era un universo inquietante, quasi infernale. Anche se rappresentava una risorsa vitale per i viaggi e le fortune dei mercanti, compresi quelli senesi: nel 1303 (il pittore Guido era probabilmente morto da poco) anche Siena avrebbe avuto il suo sbocco al mare, comprando il Porto di Talamone.
Pur seguendo le regole della pittura bizantina, Guido sa raccontarci una storia con evidenza e immediatezza. Il suo lago-mare è un mondo incantato, uno smalto verde acqua, con le onde che formano piccole increspature. In trasparenza vediamo le sagome dei pesci, delineate dal contorno nero. Qualcuno è già entrato nella rete. Grandi e piccoli, hanno forme diverse e fantasiose e quello più a destra sembra, umanamente, sorriderci. In uno spazio irreale, contro un immobile fondo oro, il pittore ci mostra a suo modo la vitalità della natura. Come nelle sue miniature: vediamo pesci simili nel Tractatum de Creatione Mundi, un manoscritto della Biblioteca Comunale di Siena attribuito a lui. Sono pesci diversi da quelli dei bestiari, che terrorizzano l’uomo medievale. Perchè nel mare abitano esseri infernali: lo storione, scaltro come il demonio, la balena, che inghiotte prede più grandi di un orso, il monaco di mare, con testa umana e due pinne al posto delle braccia. Forse, oltre ai bestiari, Guido ha guardato anche a pesci più vicini e innocui, quelli che vedeva sui banchi del mercato, a Piazza del Campo? Il pesce (antico simbolo cristologico) era un cibo comune nella cucina medievale, anche per i tanti periodi di magro del calendario, quando la carne era vietata: il mercoledì, il venerdì e i periodi di quaresima. Insieme a verdure e legumi, era alla base dell’alimentazione dei monaci. Nel Medioevo a Siena si mangiava soprattutto pesce di lago e di fiume: tinche, lucci, anguille, dal bacino della Chiana e dal Trasimeno. Si trovava anche pesce di mare, essiccato e salato. E chissà qual era il piatto preferito di Guido, se i gamberi con salsa alle spezie, l’aringa sotto sale o la pregiata tonnina.
approfondimento a cura di Marzia Minore, funzionaria storica dell’arte dei Musei Nazionali di Siena