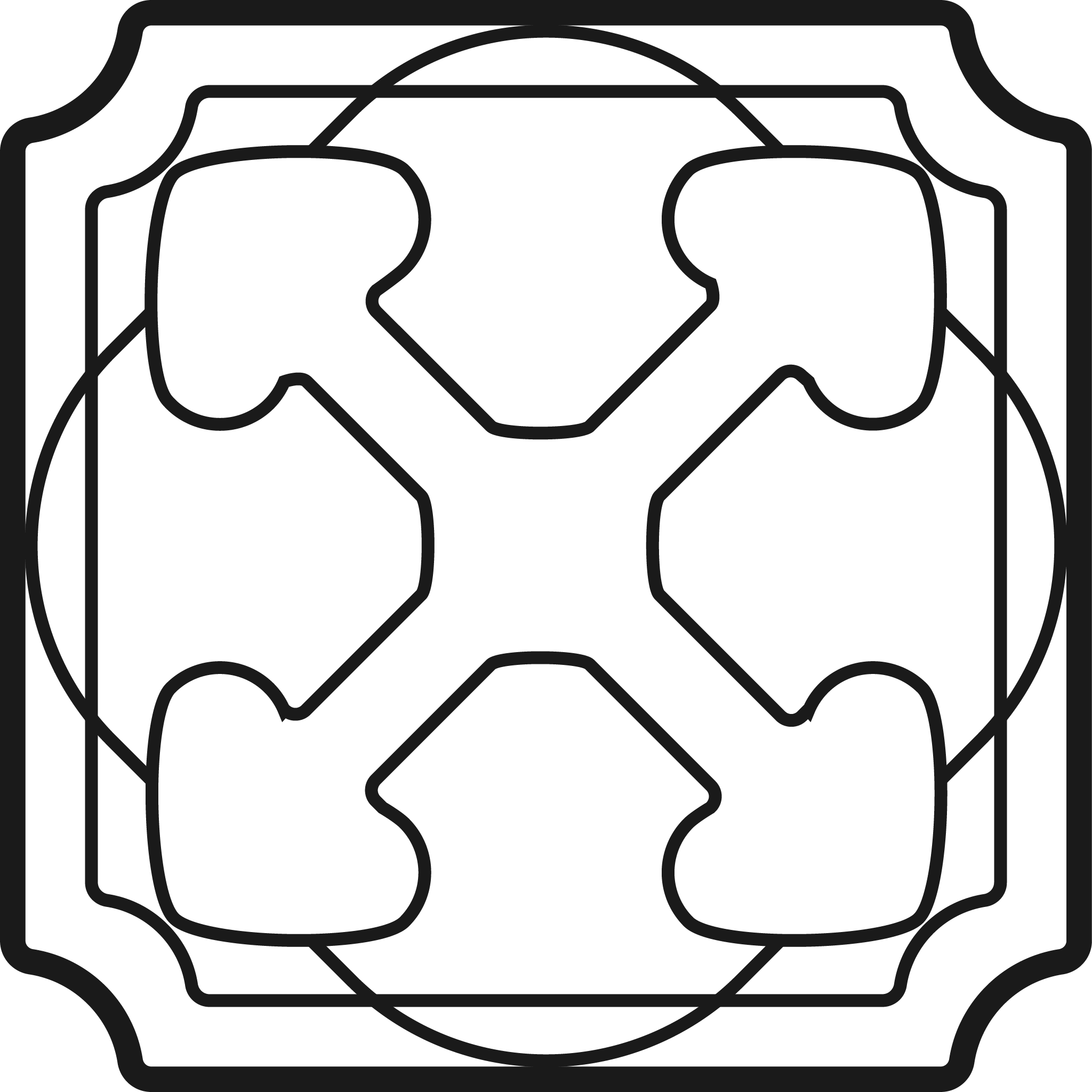
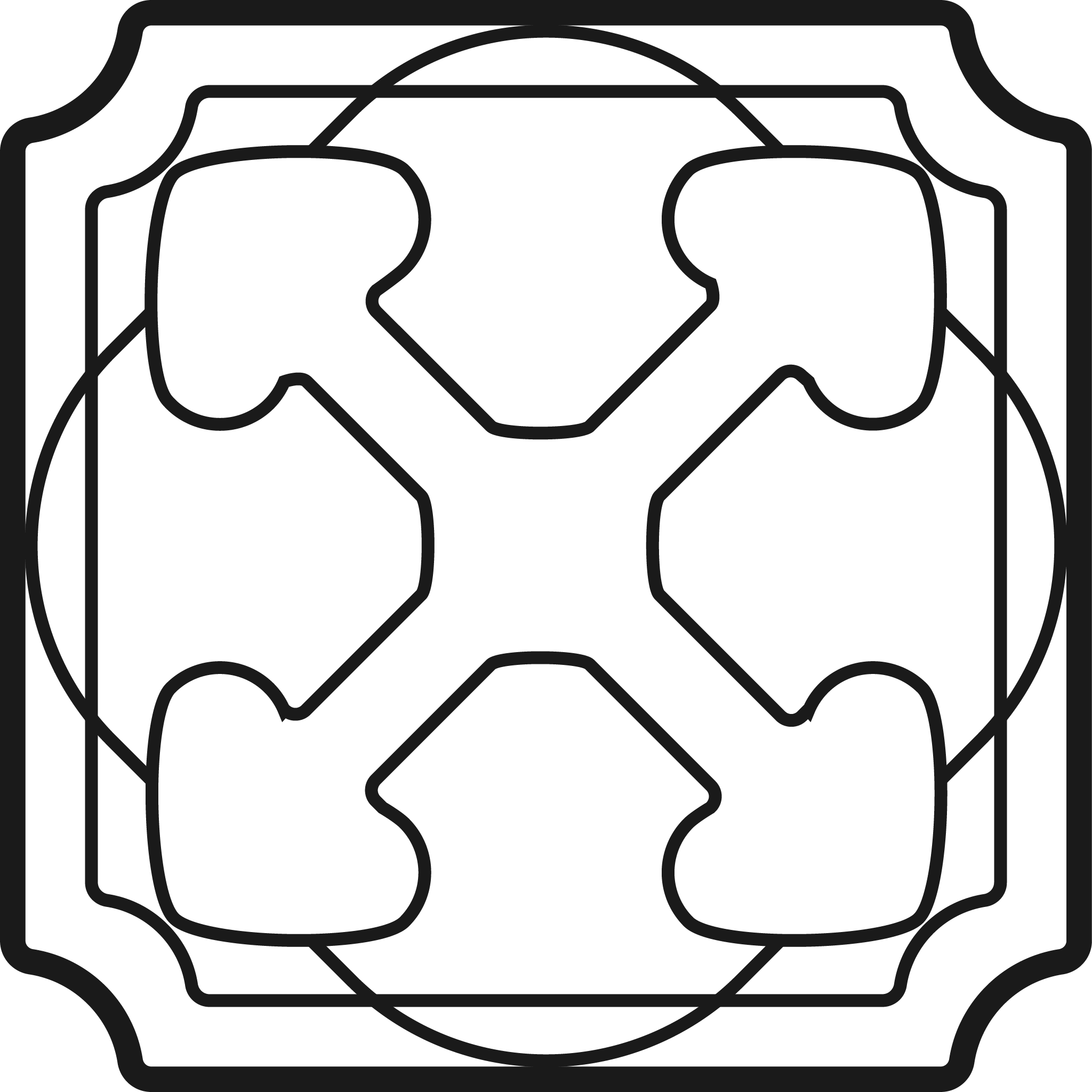
Spesso annoverati tra le pietre preziose, i coralli sono in realtà piccoli polipi che, riunendosi in colonie, formano uno scheletro calcareo dalla caratteristica forma ramificata. Il colore rosso intenso del corallo ha affascinato uomini e popoli fin dall’antichità e veniva commerciato in maniera significativa in tutto il Mediterraneo fino all’Oriente: prezioso era quello siciliano.
La sua origine è stata per secoli avvolta nella leggenda. Nelle Metamorfosi Ovidio riconduce la nascita del corallo al sangue sgorgato dalla testa recisa di Medusa e deposta da Perseo su un giaciglio di alghe marine, le quali, a contatto con il sangue della Gorgone, si indurirono.
Nella Naturalis Historia Plinio il Vecchio racconta che il corallo era considerato un rimedio contro il malocchio provocato dall’invidia, capace di ‘infilzare’ l’influsso cattivo nei suoi rami appuntiti e di deviarlo. Anche nel Medioevo e nel Rinascimento al corallo furono attribuite virtù protettive e apotropaiche: si riteneva fosse in grado di prevenire malattie, di fugare le tempeste e di cacciare i demoni. Nella simbologia cristiana il corallo rappresenta il sangue di Cristo e nei dipinti è spesso raffigurato al collo o in mano a Gesù Bambino. Era diffuso come ornamento dei reliquiari, evocazione del sangue mistico, e nel Quattrocento era spesso utilizzato nei rosari, come confermano numerosi inventari e le stesse testimonianze figurative. Era utilizzato per la realizzazione di monili, perlopiù dedicati ai bambini, uso che continuò in epoca rinascimentale e barocca, per arrivare fino a tempi più recenti. Un interessante esempio conservato nella Pinacoteca Nazionale di Siena è il pregevole dipinto raffigurante la Madonna in trono con il Bambino e quattro Angeli dell’artista senese Matteo di Giovanni (1470). Il piccolo Gesù, abbigliato con una delicata tunica trasparente, tiene tra le mani una collana di grani di corallo dal colore rosso intenso. Il corallo diviene quindi simbolo di protezione e al tempo stesso prefigurazione della Passione di Cristo.
approfondimento a cura di Giulia Cantoni, funzionaria storica dell’arte dei Musei Nazionali di Siena e di Annalisa Giovani, responsabile per la mediazione e i servizi educativi dei Musei Nazionali di Siena